Bibliografia



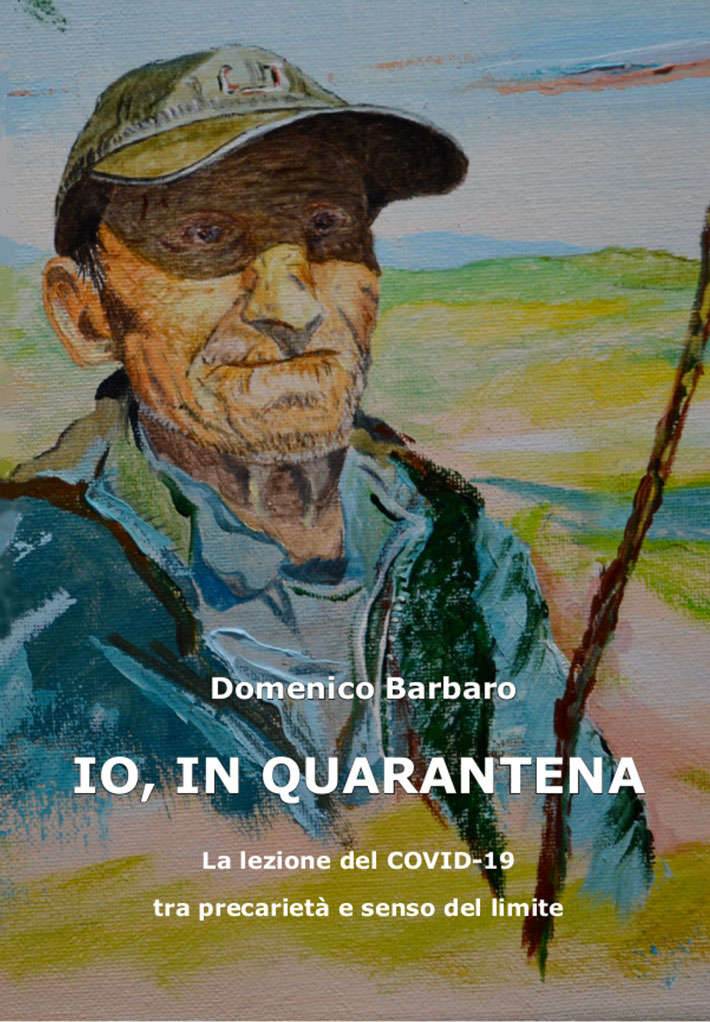

Da un Capodanno all’altro
Il testo che accompagna il libro si compone solo di alcuni spezzoni di commento
“… un racconto vero, intenso, pieno ed interessante, quasi da cronache di storia locale o di storia della medicina, una sorta di narrazione del fenomeno e del suo mutare rapportato ai vissuti interni di un protagonista della scena … il racconto scorre come il titolo afferma, “da un Capodanno all’altro” in una sorta di ineluttabilità del fenomeno che cambia ma continua ad esistere e si estende.”
(Giuseppe Mammana)
“La storia di Barbaro non è soltanto la storia della piccola Isernia, è davvero la storia del fenomeno nel nostro paese e delle risposte più o meno concrete che vi si danno.”
(Giuseppe Mammana)
“L’eroina rompe, forse irreparabilmente, un sistema delicatissimo che è nell’uomo e che garantisce il carattere finalistico di ogni azione ed ogni iniziativa: la ricerca del piacere e della gratificazione collegata alla sopravvivenza della specie.
Allorché il risultato del piacere e della gratificazione nasce in modo autonomo rispetto ad esse, azioni ed iniziative, l’uomo rinuncia a queste e si concentra su quel nuovo meccanismo attaccandovisi come all’unica risorsa che merita di essere coltivata.
In tale situazione si determina un profondo sovvertimento comportamentale, un alterato concetto della relazione, un rifiuto netto del co-esistere, uno squilibrio dell’affettività.”
(D. Barbaro – Dal libro: Da un Capodanno all’altro)
“… ora, arrivata al confine tra la vita e la morte, a 24 anni, mi rendo conto che è ora di dover pensare ad una vera vita, di voler ricominciare a credere nelle cose semplici, quotidiane.
Voglio tornare ad essere l’Anna di una volta, quella persona alla quale tutti dicevano: “- Hai sempre il sorriso sulle labbra… quando ti vedo mi dai felicità”.
Voglio che torni a bastarmi questo per essere felice, vera e serena.
(Anna, morta successivamente per overdose. – dal libro: Da un Capodanno all’altro)

Se Giulio non cambia…
Tutte le storie degli uomini hanno un senso, anche quelle che sembrano non averlo, quelle – dico – fatte di una successione, che pare proprio ineludibile, di delusioni, sconfitte, amarezze, drammi. Quelle in cui l’istinto della ribellione è più immediato e più intenso. Quelle in cui vorresti capire al momento il perché di un certo evento, ed esigeresti, in una condizione assolutamente umana, una plausibile risposta.
Ma non è possibile averla se l’evento non diviene passato, schiudendosi alla visione complessiva di un progetto unitario che, per chi crede, rappresenta il misterioso disegno definitivo di salvezza. Per gli altri, forse, una più o meno esaltante avventura, spesa a dominare il destino e piegarlo al proprio immanente disegno esistenziale. La forza del cambiamento.
Abbiamo sfidato la vita io e Giulio. Seppure in colori e contesti diversi. Lui tra il verde vivo delle montagne del Matese e delle Mainarde, io avvinto al colore, a tratti cinereo, delle montagne d’Aspromonte, che simbolicamente cantano la fragilità dell’esistenza in quel loro disfarsi e scendere a valle, spesso rovinosamente.
– Domenico Barbaro
Il romanzo “Se Giulio non cambia…” intreccia la storia molisana di Giulio e della sua famiglia con la storia calabro- aspromontana dell’Autore bambino e della sua famiglia. Sullo sfondo una sottile analisi sociologica dell’ambiente antropologico dell’Aspromonte degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo appena trascorso e quella del comprensorio montano del Matese e delle Mainarde ricadente nella provincia di Isernia, la Pentria dell’antico popolo dei Sanniti.
Si attua così, spontaneamente, un ideale gemellaggio tra Calabria e Molise, tra due mondi rurali assai simili pure nei valori familiari e nelle tradizioni sociali, ma anche nelle involuzioni di un falso progresso consumistico-tecnologico che espone, specialmente i giovani, ai pericoli delle devianze mortali.
“Se Giulio non cambia…” si legge tutto d’un fiato, con picchi di commozione che possono portare a vere e proprie lacrime, e ci spinge ad interrogarci sulle nostre responsabilità personali in un siffatto contesto. La lettura di queste pagine è fortemente consigliata nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni, ma soprattutto nelle famiglie e nelle altre istituzioni pure come incisivo momento di “pedagogia sociale”. Possiamo ben dire che questo romanzo è il libro “Cuore” del contrasto alle tossicodipendenze. Ed è, comunque, una storia che apre decisamente alla speranza.
– DOMENICO LANCIANO, giornalista
Presentazione del libro “Se Giulio non cambia…” al mio paese di origine.
La sala era la stessa, quella del vecchio cinema parrocchiale, dove un tempo lontano scorrevano davanti ad una platea curiosa e sorpresa le immagini, dapprima in bianco e nero e poi a colori, di film western e di innocenti storie d’amore. Per questo, mentre vivevo l’emozione dell’evento, avevo l’impressione di sentire ancora là dentro le voci di Clark Gable, Amedeo Nazzari, Cary Grant, Robert Taylor. Naturalmente le scene più ardite erano anche qui sottoposte a censura. Proprio come in Nuovo Cinema Paradiso. Ed io inevitabilmente mi ritrovavo a vestire i panni di Totò, il chierichetto che con la sua devozione si guadagnava un posto gratis al cinema.
Questa l’atmosfera che respiravo la sera del 23 agosto scorso alla presentazione del mio libro. In platea c’era la gente di oggi, i figli di quei padri che avevo conosciuto negli anni della mia fanciullezza. Nei loro sguardi scorgevo gli stessi sguardi comprensivi dei loro padri, lo stesso affetto, lo stesso sentimento di profonda solidarietà. La sala era gremita e la cosa mi provocava un’intensa commozione. Ero soddisfatto di aver raccontato storie che essi conoscevano appena, ma di cui abbondantemente avevano parlato i loro padri.
C’erano anche presenze del mio tempo. Mi indispettiva non aver conservato completa memoria di nomi e di appartenenze. Ma erano volti esattamente come il mio quelli che avevo davanti, con i segni del tempo che passa inesorabilmente e disegna di bianco i radi capelli sopravvissuti. Queste presenze le percepivo d’una emozione diversa, di sicuro più intensa. Loro le mie esperienze le conoscevano bene, ed avevano condiviso la mia ribellione, la mia stessa voglia di riscatto, il mio desiderio di speranza e di futuro, pur non essendo mai saliti su un treno che li avrebbe portati lontano. Lo avevano trasmesso bene questo desiderio. Tanto che i loro figli lo esprimevano chiaramente ora questo scatto di orgoglio con la loro coinvolta partecipazione all’evento.
Hanno parlato di cultura i giovani di Platinsieme. Hanno compreso molto bene che il futuro passa da qui, dall’orgoglio dell’appartenenza, dalla dignità che nessuna povertà può uccidere, dal sapere che scuote le coscienze e le guida verso il più autentico riscatto, verso un deciso e radicale cambiamento.
Perciò sento di dover ringraziare proprio loro, questi giovani che con il loro impegno ci hanno dato, nell’organizzare benevolmente questo estivo evento culturale, una lezione da non dimenticare.
– Domenico Barbaro
Platì, agosto 2014

La Pedagogia dell’onnipotenza
La pedagogia dell’onnipotenza.
(Dal sentimento di onnipotenza al disturbo depressivo)
Ho pubblicato questo terzo libro per non commettere un peccato di omissione. Non potevo, cioè, sottrarmi al dovere di esprimere, a beneficio di chi potrebbe leggermi, l’evidenza di un meccanismo spesso presente nel determinarsi di un disturbo del versante affettivo, e non solo. È naturale che il sentimento depressivo possa derivare da un evento doloroso della vita. Ma esso nasce anche quando le aspettative dell’uomo sono ridondanti rispetto alle sue reali possibilità in merito alle vicende della vita quotidiana. E queste aspettative, dettate da un Super-Io ipertrofico, sono correlate ad un diffuso sentimento di onnipotenza che oggi pare aver contagiato irrimediabilmente l’uomo.
Da dove può nascere questo sentimento eccessivo se non da una dilagante cultura dell’onnipotenza, che appare sempre più affermarsi in ragione delle conquiste tecnologiche, ma certamente anche a motivo di una vera e propria pedagogia dell’onnipotenza mediata da una comunicazione profondamente sovvertita?
La famiglia e la scuola hanno perduto ormai, come si sa, il ruolo esclusivo di agenzie formative e ne hanno perfino sottratto la consistenza. La formazione dei giovani e dell’uomo in generale è stata assunta sempre più dai media che posseggono strumenti più penetranti ed assolutamente insidiosi. Mi riferisco non tanto alla TV o alla carta stampata, ma al Web che spadroneggia nell’informazione in comunanza con il cellulare divenuto, lo dico con una metafora, “il mondo in tasca.”
La pedagogia mediatica è divenuta così la pedagogia dell’onnipotenza. Essa è strutturata prevalentemente non da messaggi verbali, ma da modelli, da immagini, da suggestioni che ricreano un uomo forte, perfetto, bello esteticamente, vincitore in qualsiasi condizione, dal potere smisurato, dallo sguardo illimitato, senza orizzonti o confini, dalle capacità infinite. Un uomo-dio, insomma. Un uomo convinto di non avere ostacoli, di poter schivare la sofferenza, di poter fare a meno di qualsiasi altro dio. Non per niente si va sempre più oscurando la dimensione trascendente e si va imponendo contestualmente una visione atea ed esasperatamente materializzata del mondo.
In questa spocchiosa ascesa dell’uomo contemporaneo non c’è spazio per le sconfitte, le delusioni, la sofferenza, la morte. Queste cose sono censurate, negate, ostinatamente rimosse. Abbiamo ricreato la società dell’edonismo più esasperato, del benessere a tutti i costi, degli incantesimi, fino all’approdo a un mondo virtuale dove si è prodighi solo dei “mi piace”, pretesi anche se non meritati, dove le relazioni si snodano con una velocità incredibile, con una superficialità disarmante e con una emotività stantia e mendace, dove emozioni e sentimenti sono delegati ai cosiddetti emoticon.
Allora, la delusione che la realtà esistenziale impone non si trasforma soltanto in depressione, che pure rappresenta l’espressione congrua di una ferita subita, ma si trasforma soprattutto in un sentimento di fallimento cosmico, di definitiva e bruciante sconfitta che può condurre ad una rabbia mai sopita, quando se non al rifiuto della vita stessa.
Oltre questa reazione depressiva ci sono anche altri possibili effetti della pedagogia dell’onnipotenza, e sono quelli più devastanti.
Probabilmente, ad esempio, siamo restii o forse rinunciamo a credere che il femminicidio possa derivare da questo sentimento di onnipotenza che rende l’altro il proprio oggetto d’amore, esclusivo ed irrinunciabile. In realtà è proprio quando si profila una perdita che l’idea del possesso può facilmente trasformare l’uomo in assassino. C’è qui l’incapacità di perdere, l’incapacità di sopravvivere a questo affronto, ed insieme il desiderio inconscio di introiettare l’oggetto d’amore in una suggestione di relazione simbiotica, non più possibile dopo quella materna. Sono entrambi dettati dal sentimento di onnipotenza.
Anche per il bullismo c’è da fare una simile riflessione. Esso è l’epifenomeno della stessa dinamica di autoesaltazione.
Ecco perché credo che non esista legge punitiva, né proclama sterile, né corteo di solidarietà che tenga. Bisogna prendere coscienza di questo meccanismo e promuovere una cultura che sia controcorrente, che sappia ridimensionare questa idea eccessiva della vita e delle sue vicende esistenziali. Solo così potremo sconfiggere seriamente femminicidio e bullismo.
L’ossessione di internet, dei social, dei reality, delle dipendenze di vario genere, conduce ad una inevitabile prevaricazione della condizione umana e ad un’auto esaltazione e celebrazione fino al punto di sviluppare una tolleranza zero ai minimi segni che fanno riferimento alla fragilità umana. Si è così disponibili ad ostentare solo la propria forza e la propria spavalda performance. Mi viene in mente la campagna per le presidenziali in America. Una guerra condotta anche a suon di certificati di ottima salute. Come dire la scelta di un uomo che coniughi il suo potere politico alla prestanza fisica, alla sua immagine performante, al suo successo personale, alla sua spettacolare condizione sociale. Ma come sarebbe bello pensare invece che anche con un fisico debilitato, stanco e fragile si può essere in grado di governare perseguendo il bene comune. Esempio indimenticabile Giovanni Paolo II.
Il linguaggio violento della politica che si sovrespone e della stampa che vi si accoda costituisce un modello profondamente negativo. Per sostenere la violenza spesso si sacrifica anche la verità. L’equivoco di un uomo-dio viene brandito come una conquista reale che consente di superare e forse anche di ignorare ogni principio etico e morale, oltre che una possibile dimensione trascendente.
Nella cronaca recente si è parlato di una coppia, lei infermiera e lui medico, che apertamente si sono attribuiti il potere della vita e della morte, usurpando il ruolo del vero Dio. Lei si rivolge a lui: “- Tu sei l’uomo più importante del mondo” e lui risponde: “- Io di fronte gli ammalati sono dio.” Qui c’è la formale ed esplicita dichiarazione di questa incredibile patologica metamorfosi dell’uomo contemporaneo.
Nei casi clinici compresi nel libro questi meccanismi si svolgono al livello inconscio ostacolando spesso sia la coscienza di malattia sia il possibile accesso ad una relazione terapeutica.
Il percorso riabilitativo è esattamente inverso a quello della cultura corrente. L’obiettivo fondamentale è dunque la cultura del limite che sappia professare la propria fragilità. Questo è il messaggio autentico e sostanziale. Bisogna fare attenzione a non farsi penetrare dalla pedagogia dell’onnipotenza che i media profondono in tante forme. Ritornare alla cultura del limite vuol dire assumere la propria fragilità come condizione per incontrare l’altro nella reciprocità, che è requisito inderogabile per “vivere-insieme-nel-mondo”.
La cultura del limite è la sola arca di salvezza in questo diluvio universale per sfuggire ad uno dei più importanti fattori di rischio del dilagante disturbo mentale.
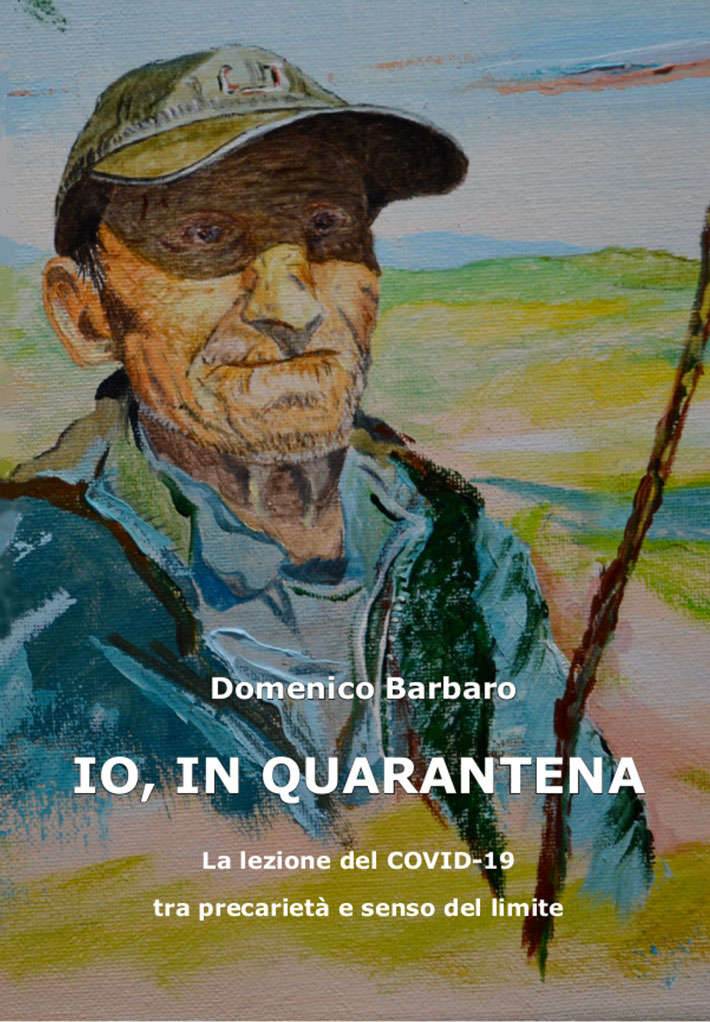
Io, in quarantena
Nel mezzo di questa strana estate del 2020 ho ricevuto la bozza di questo libro con un preciso mandato: essere critica e severa, esprimere un giudizio di merito, non condizionato dalla nostra conoscenza, dalla nostra stima reciproca e dagli affetti costruiti e consolidati nel tempo.
Nel leggere queste pagine, mi sono più volte interrogata sul significato di quel compito, trovando forse la risposta proprio nel bisogno del limite da parte di colui che me l’ha assegnato.
In quella richiesta, così esplicita e diretta, di essere neutrale, di tracciare un perimetro ai pensieri e alle emozioni che hanno dato vita alle riflessioni di questo lavoro, ai vissuti generati durante la chiusura imposta da quello che può a ragione essere considerato come l’evento più forte e pregnante della nostra epoca, l’epidemia Covid 19, sembra annidarsi la necessità di affidarsi all’altro come guardiano vigile di quella che potrebbe essere la sua di onnipotenza.
L’onnipotenza, un tema a lui caro, un’urgenza mai sopita, che necessita dunque di essere ancora raccontata, scandagliata, analizzata, sviscerata, soprattutto alla luce di quanto accaduto a partire dallo scorso marzo, quando in Italia, e successivamente nel resto del mondo, è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il tempo in cui fuori imperversava il virus, mentre ci riparavamo dentro le nostre case, diventa quindi occasione di un racconto, di un dialogo con il lettore, che viene continuamente sollecitato a riflettere e, soprattutto, a cogliere nell’evento traumatico che ci ha riguardato tutti, nessuno escluso, un’opportunità per pensarci e ripensarci, per salire sull’ Arca del limite e salvarci dall’onnipotenza, non più aggettivo che dovrebbe qualificare alcuni aspetti delle nostre vite, ma sempre più sostantivo che quantifica troppa parte dell’agire umano.
Nei vari capitoli sono descritti i modi in cui le dinamiche dell’onnipotenza agiscono in diversi campi del nostro vivere quotidiano, dalle relazioni al corpo, dalla comunicazione alla politica, viene mostrato come la grandiosità, la negazione dell’altro, lo sconfinamento e l’abbattimento del limite, l’escalation competitiva, il Super Io ipertrofico, che sempre meno codice etico per connotarsi sempre più come codice estetico, rischiano di farci perdere di vista noi stessi e gli altri.
Le restrizioni e i limiti a cui ci ha costretto questo virus, il reale che ci ha presentato, con i numeri del bollettino delle 18:00, con le immagini delle bare di Bergamo, con le terapie intensive troppo piene e le case dei nostri nonni troppo vuote, dopo una prima fase di disperazione, di sconvolgimento, di rabbia, di angoscia, potrebbe diventare una possibilità di trasformazione.
“Non possiamo lasciare questo passaggio epocale in mano al caso, non possiamo lasciare che questa quarantena sia trascorsa invano”
Il cambiamento dovrà cominciare dal mondo adulto, mentre il presente e il futuro sono consegnati alla generazione post coronavirus, che potrà davvero contenere in sé il germe della rinascita e riorganizzare il mondo post pandemia, se saprà guardare al passato custodendo la memoria dei nonni.
I nostri nonni. Loro il rammarico più grande. Quello che forse non si potrà perdonare a questo terribile virus, più del tempo, più delle stagioni, più degli abbracci, è di averci sottratto i nonni.
Per loro sono tutte le carezze, la commozione e la tenerezza, a loro sono dedicate con amore le parole di questa intensa e appassionante lettura.
– Dott.ssa Giulia Capone
Psicoterapeuta sistemico relazionale ad orientamento psicodinamico
Ho voluto dedicare questo libro ai nostri nonni che in questo tempo di pandemia ci hanno lasciato e in punta di piedi sono andati via. Non c’è stato alcun modo di salutarli. Eppure, sono stati loro la vera, grande ricchezza del nostro Paese. Sarebbero stati loro a trasmetterci la lezione sul nostro limite e sulla nostra fragilità.
Noi invece li abbiamo emarginati, li abbiamo relegati in strutture chiuse e spesso inaffidabili. Noi li abbiamo considerati superflui e inutili per questo nostro mondo borioso e arrogante. Con il diffuso sentimento di onnipotenza abbeverato alla cultura del nostro tempo li abbiamo allontanati per una forma di censura collettiva, perché essi ci ricordavano il tempo del declino, il tempo del tramonto della vita, il tempo delle malattie e della sofferenza.
Loro sì, erano stati posti in quarantena in anticipo, quando invece noi avevamo piena libertà di correre e sfidare tutto per una collettiva e farneticante ambizione di arrivismo ed edonismo. Per noi rappresentavano il limite, la fragilità, l’incapacità e perciò ne abbiamo fatto un mondo altro da noi.
Un agglomerato proteico invisibile e inaspettato ha messo questa volta noi in quarantena, ma ci ha sottratto proprio loro, la nostra vera ed unica ricchezza, le nostre radici, la nostra memoria del passato, la nostra storia.
Sono andati via senza una carezza, senza un segno di tenerezza. Forse oggi c’è in noi forte il rimorso di averli lasciati soli, di non essere riusciti a contornarli di quel tepore affettivo che noi invece avevamo ricevuto da loro, di non averli saputo proteggere.
Ora sembra davvero che ci manchi la terra sotto i piedi. E il nuovo mondo, quando sarà passata questa pandemia, sarà certamente più povero senza di loro.
– Domenico Barbaro 27.04.2020
