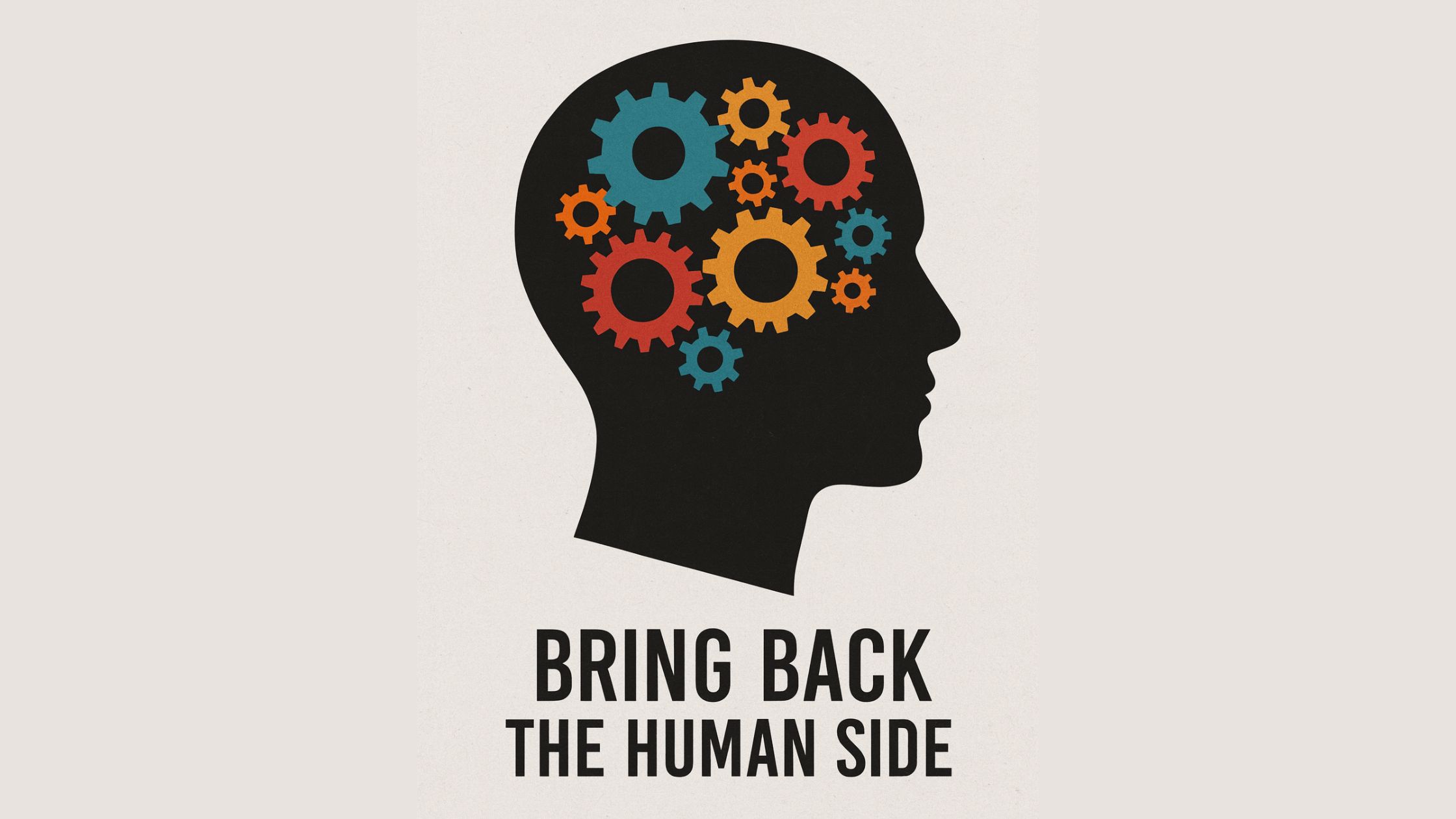In un tempo così disumanizzato e cinico, come quello che stiamo vivendo, oltre l’agonia della psichiatria (così come scriveva Eugenio Borgna) mi sembra di assistere, ahimè, all’agonia di un po’ tutte le discipline mediche. A fronte degli incredibili progressi scientifici, in grado di alimentare in chi soffre sempre più fondate speranze, vedo spesso diffondersi negli operatori sanitari una esclusiva attenzione più sulla malattia che sul malato.
Questa propensione che privilegia l’iter diagnostico basato sull’abbondanza di indagini strumentali e bioumorali, trascurando, spesso colpevolmente, i dati anamnestici e più ancora la “narrazione” che il paziente vorrebbe fare della sua sofferenza, sottrae al rapporto medico-paziente la ricchezza di quegli aspetti emozionali che accompagnano la malattia, e conseguentemente lo sviluppo di quell’elemento, indispensabile nella relazione, che si chiama empatia.
La persona che soffre porta con sé una modalità unica di filtrare il dolore oltre ad un bagaglio di situazioni ed esperienze esistenziali che conferiscono al caso clinico una complessità ed una singolarità che richiedono un ascolto attento, comprensivo e solidale. Ne deriva “una storia esclusiva” entro la quale bisogna tentare di entrare non per emettere un giudizio etico, ma per scandagliare, nello spirito di condivisione, quel mondo delle emozioni e dei sentimenti che utilizza gestualità, sguardi, e perfino silenzi, per illuminare quei fondali inesplorati della mente dove il bisogno dell’altro è nutrimento imprescindibile. Solo così il rapporto con il paziente può ritornare ad una sua doverosa umanizzazione conferendo alla prestazione sanitaria la sua giusta completezza.
Quando negli anni Novanta si cominciò a parlare di aziendalizzazione dell’offerta sanitaria e di prevalenza del criterio economico ho giudicato per mio conto che non potesse essere prodotta l’offerta sanitaria alla guisa della produzione di scarpe. La dannata esigenza di produrre quantità e non qualità era forzatamente legata alla funzione tempo. Come dire che bisognava affrettarsi a produrre sempre di più. Per raggiungere, appunto, i cosiddetti “obiettivi aziendali”.
Anche le parole hanno la loro importanza. Dire azienda anziché servizio non è un trascurabile scambio di parole. Così come sostituire l’attributo primario con il termine direttore non è una innocente modifica di denominazione. È una modalità subdola di capovolgere, o meglio stravolgere, la cultura della tutela di quel bene fondamentale che è la salute.